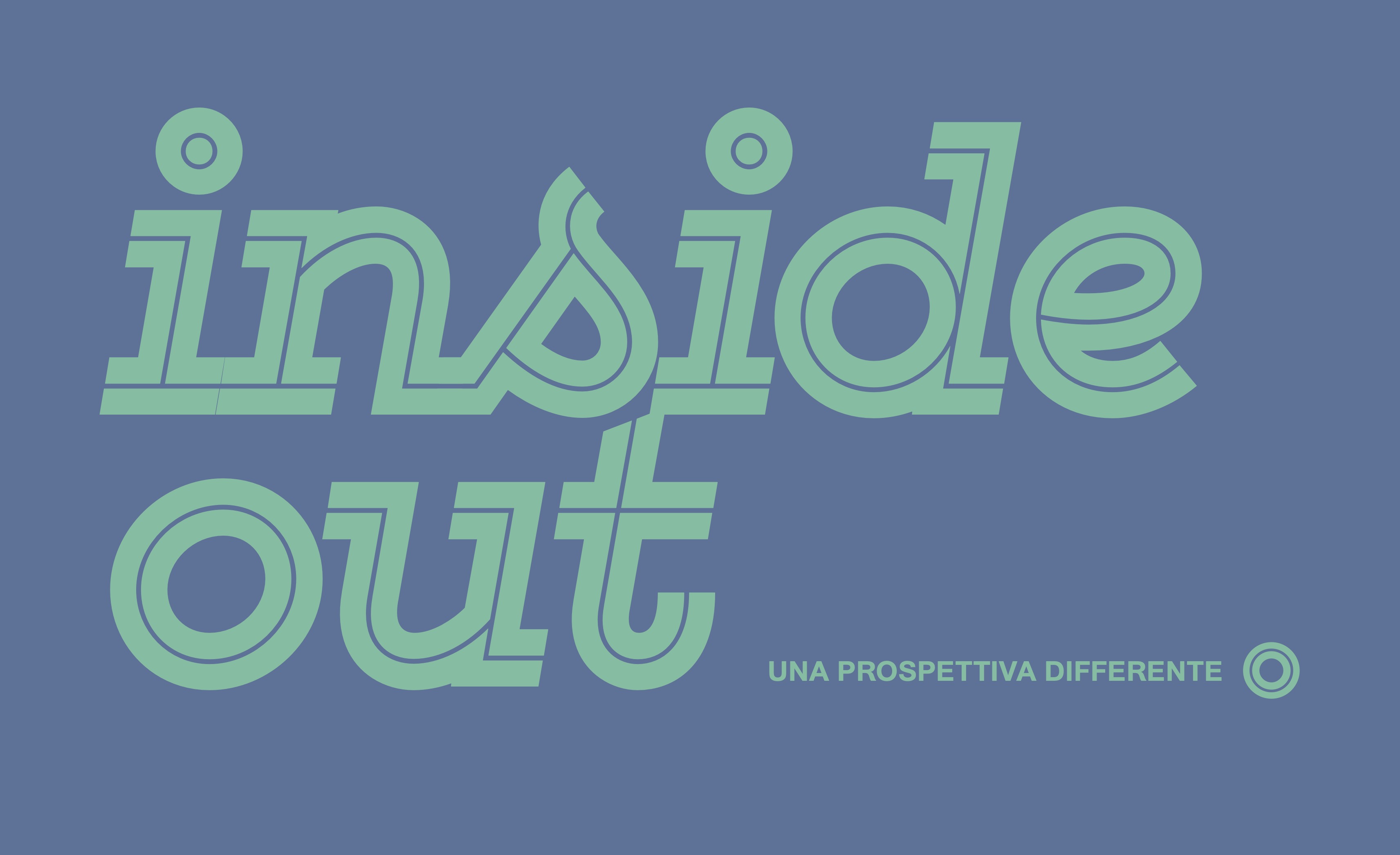Cosa significa lavorare (e vivere) da expat nella Silicon Valley? Parla Federico Francioni, Head of Digital Ecosystem di Meta.
Trasferirsi per lavorare in quello che a ragione rappresenta il regno della tecnologia globale non è un’operazione semplice: le incognite sono molteplici, così come le sfide che ci si ritrova ad affrontare da expat sul nuovo posto di lavoro. Soprattutto ora, considerata la congiuntura economica negativa che sembra stia colpendo i giganti attivi nel settore tecnologico in questo inizio 2023: licenziamenti di massa, inflazione alle stelle, aumento dei tassi di interesse, ritorno a vecchie abitudini di consumo. Abbiamo parlato di questo e molto altro con Federico Francioni, Head of Digital Ecosystem per Meta: quella che può essere considerata, senza fare torti a nessuno, una delle più influenti big tech al mondo. Federico è nato ad Arezzo nel 1982 ed è expat in California dal 2013. Lavora nella sede centrale di Meta a Menlo Park, nella San Francisco Bay Area, uno dei centri principali, se non il primo in assoluto, della Silicon Valley.
Federico si collega: l’inquadratura su di lui è inondata dal sole e dalla luce satura della California. In Italia sono le 20 di un venerdì sera freddo e piovoso di gennaio.
Sei a casa oggi?
«Oggi si. Raramente il venerdì vado in ufficio. In generale nessuno in America va in ufficio il venerdì».
Lascio che Federico racconti qualcosa della sua vita quotidiana. «Mio figlio ha 6 anni e fa la prima elementare, ma è come se l’avesse, di fatto, già iniziata l’anno scorso: qui al Kindergarten (l’asilo americano, ndr) i bambini imparano a leggere e scrivere. Ora legge e scrive come io probabilmente leggevo e scrivevo in quarta elementare. Sono delle macchine».
Di cosa ti occupi esattamente in Meta e com’è strutturata la tua giornata tipo?
«Sono responsabile per l’Employee Experience, quindi l’esperienza dei dipendenti di Meta sulle nostre piattaforme digitali interne. Tutto quello che ricade nel campo dell’HR lo seguo io tramite queste piattaforme. Il mio lavoro, in sostanza, consiste nel creare un ponte tra il dipartimento delle risorse umane e quello di ingegneria, che disegna e implementa questi strumenti interni. Generalmente, i miei meeting iniziano tra le 7.30 e le 8 del mattino e finiscono alle 16. Quasi tutti della durata di 30 minuti e non si sfora mai».
Lavorando per i servizi ai dipendenti, cosa noti in questo momento particolare? Cosa chiedono le persone, considerando soprattutto il tema del remote working?
«È chiaramente il tema degli ultimi tempi. Noi, come azienda, ad oggi non abbiamo ancora deciso di far tornare tutti in ufficio, a differenza di quanto hanno fatto Apple, Google, o Twitter. Siamo un po’ più aperti su queste dinamiche, che vengono stabilite a livello di team. In generale, negli ultimi due anni stiamo cercando di capire come si riesca a lavorare bene da remoto quando tutti sono in remoto, come gestire al meglio la transizione quando saremo hybrid, cioè quando alcuni saranno in ufficio e altri in remoto, e come organizzare in maniera ottimale giornate in cui ci si trova in ufficio e altre in cui si lavora da soli. In Italia si usa il termine smart working per quello che in realtà è puro remote working. Ma il remote working non è, per definizione, smart, non ha nulla di intelligente, così come quello che viene chiamato smart working non può significare, nella pratica, un dipendente costretto a stare 8/9 ore fisso a un pc, magari lavorando e producendo, effettivamente, per 4 di quelle stesse ore. Mi spiego meglio: fai davvero smartworking quando riesci a lavorare da remoto per obiettivi e occupando esattamente il tempo necessario per raggiungerli, senza dover per forza andare oltre».
Come mai, secondo te, in Italia si fa fatica a implementarlo in maniera sistemica?
«In Italia abbiamo dei grossi problemi perché fondamentalmente il sistema non si fida del dipendente. È un tema culturale: un approccio diametralmente opposto a quello americano, dove esiste una work ethic per cui il tema non è nemmeno in discussione. In America tu hai fiducia di chi viene a lavorare per te, e infatti il contrappasso è duro e puro: se sbagli sei fuori. Le persone perciò, non hanno motivi per fare i furbi: hanno più motivi per comportarsi bene e produrre, perché sono incentivate a farlo, motivate anche dalla stima e dalla fiducia di base che il datore di lavoro riversa nei loro confronti. Tanta è la fiducia e l’affiliamento del dipendente, quanto eventualmente veloce è il suo licenziamento non appena ce ne sia una qualsiasi motivazione: qui funziona così. In Italia, purtroppo, c’è e probabilmente ci sarà sempre la “cultura del furbo.” Un approccio, senza dubbio, retrogrado: viene privilegiato il controllo fine a se stesso rispetto alla misurazione delle performance. Un sistema che non fa bene né al lavoratore, né all’azienda. Qui non interessa a nessuno se lavori 5 ore al giorno o 10. Anzi, probabilmente se ne lavori 10 ti dicono pure qualcosa. Allo stesso modo, se tu dici di essere un “night owl” (un “nottambulo”, ndr) per cui sei più comodo a lavorare la notte consegnando entro la mattina, nessuno ha problemi. È tutto più fluido, e di conseguenza anche il posto è meno importante. Se non sei fluido all’origine è inutile parlare di smart working, perché stai facendo tutto in maniera dumb».
Tornando a te: come mai hai deciso di trasferirti in California? Quando è successo, e come?
«Non credo di averlo mai deciso formalmente. Sapevo, quello sì, che volevo fare il mio mestiere nel posto più avanzato in cui lo si potesse fare. Avevo questo richiamo della Silicon Valley pur non essendoci mai stato. È stata una sorta di “vibe”. Certo, se è vero che inconsciamente non era pianificato, di fatto però lo è stato: ho lavorato giorno dopo giorno per trovare connessioni, aziende, ottenere i visti, e tutto ciò che serviva per raggiungere l’obiettivo. Ho cambiato posto di lavoro per rendere reale questo trasferimento. Il mio capo referente all’epoca decise di spostarsi in un’altra azienda del settore mantenendo alcuni della sua squadra, io al contempo stavo capendo come riuscire ad andare negli Stati Uniti, e sapevo che questa multinazionale mi avrebbe dato più possibilità grazie ad un’iniziativa di mobilità globale. Perciò ho seguito il mio referente, complice anche un upgrade nella mia posizione lavorativa, e nel frattempo ho continuato a monitorare cosa l’azienda faceva negli USA, chi potevo conoscere, cosa facevano in Silicon Valley. Utilizzavo molto il social network interno della società per farmi conoscere e notare internamente, anche a livello internazionale. Arrivata la proposta, ho messo in atto il trasferimento, anche se non sono mancati gli intoppi. Sono infatti arrivato qui senza nessun “tutor”, ma è andata bene. Il resto è storia: sono poi passato in Microsoft, successivamente in Facebook, che ora è appunto Meta. Sono arrivato nel 2013, quest’anno sono 10 anni.”
Ti manca l’Italia?
«Mi mancano alcune cose, soprattutto alcune persone dell’Italia. Mi piace tornarci, e sono fortunato ad averne la possibilità: in Meta abbiamo i cosiddetti “Global Travel Day” che ci permettono di lavorare fino a 20 giorni l’anno dislocati, che si aggiungono ovviamente alle vacanze. In sostanza, riesco a farmi almeno un mese e mezzo in Italia tutti gli anni: il tempo giusto per godermela e stare con le persone che mi interessano. Certo, mi mancano gli amici “veri” e le connessioni potenti, forti, belle dell’Italia, quelle che qui non riesci ad avere: gli amici più stretti sono sempre quelli italiani».
Qual è il tuo punto di vista sui vasti layoff delle big tech? Che cosa sta succedendo?
«Sono numeri che indubbiamente fanno impressione. Non sono un esperto di economia, ma posso dire che sono in atto grosse pressioni da parte della finanza su tutte le aziende, incluse quelle del comparto big tech. Detto questo, trovo sia molto difficile che le aziende tech falliscano, perché molte, se non tutte, possiedono una quantità considerevole di asset immateriali. Capisco la recessione, si tratta di cicli, capisco anche che è impossibile vedere aziende che crescono del 30% ogni anno per diversi anni di fila; quindi, chiaramente questo movimento al rialzo doveva a un certo punto fermarsi e invertire la rotta, con uno sprofondamento forte. Ci troviamo in una fase senza dubbio complessa. Se l’alternativa però è, come spesso accade in Italia, trascinare uno zombie fino al momento del collasso, trovo sia meglio tagliare subito “l’arto in putrefazione” rispetto a morire lentamente dopo anni di agonia. Dal picco di crescita nel quale ci trovavamo prima della pandemia, ora abbiamo raggiunto il punto più basso. Per le tech company, comunque, quest’ultimo anno nel complesso non è andato male. Certo, ci sono alcune società che hanno perso più di altre».
Un altro fenomeno interessante è che da ormai un paio d’anni la California sta perdendo una quantità rilevante dei suoi residenti: la popolazione continua a diminuire anziché aumentare, qualcosa che non si vedeva da decenni. I californiani continuano a migrare, per la maggior parte, verso Texas e Florida, a fronte di una tassazione senza dubbio più favorevole e un costo della vita nettamente più basso. Com’è la situazione?
«Indubbiamente si può parlare di esodo, principalmente per un discorso di tassazione. Il Texas e la Florida sono Stati in cui, dalla pandemia in avanti, ci si riesce a trasferire senza nemmeno subire, a volte, cambi di stipendio. Chiaramente, trasferirsi in uno Stato pagando una percentuale considerevole di tasse in meno, a parità di entrate, si traduce in un potere d’acquisto incredibile. Ma conviene in ogni caso: anche se lo stipendio viene ridotto fino a un 20%, come accade di recente, vale comunque la pena perché il costo della vita è davvero basso rispetto ad altri Stati. Ho amici che si sono spostati dalla California 6 anni fa, ben prima che questo fenomeno diventasse di massa, e mi dicono “qui il mio potere d’acquisto è incredibilmente più alto”. In California, d’altro canto, la bolla immobiliare si è leggermente fermata, i valori sono un po’ scesi, ma si tratta sempre di numeri proibitivi, e il costo della vita resta altissimo. Per fare un esempio pratico, l’asilo di mio figlio è costato 20.000 dollari l’anno. È anche vero che gli stipendi sono commisurati».
Uno sguardo duplice, quindi, quello dell’expat, in grado di tenere assieme la prospettiva del paese di provenienza – in questo caso, l’Italia – e di quello di residenza, alla ricerca della formula lavorativa più adatta a navigare l’attuale panorama occupazionale.
*Nell’immagine in evidenza la sede Meta in cui lui lavora Federico Francioni, a Menlo Park.